 Le differenze di genere pesano ancora, e non poco; soprattutto nel mondo del lavoro. Si stima che a livello europeo vi sia una disparità retributiva media tra uomini e donne (in favore dei primi) che si attesta attorno al 16%. Per eguagliare i redditi percepiti in media da un uomo nel 2012, una donna avrebbe dovuto lavorare fino al 28 febbraio di quest’anno (418 giorni di calendario).
Le differenze di genere pesano ancora, e non poco; soprattutto nel mondo del lavoro. Si stima che a livello europeo vi sia una disparità retributiva media tra uomini e donne (in favore dei primi) che si attesta attorno al 16%. Per eguagliare i redditi percepiti in media da un uomo nel 2012, una donna avrebbe dovuto lavorare fino al 28 febbraio di quest’anno (418 giorni di calendario).
A parità di prestazione professionale offerta, di mansione svolta, di ore quotidiane dedicate all’attività lavorativa la donna sembra non vedere riconosciute le proprie qualità. Anche perché, secondo le statistiche ufficiali, il 60% dei laureati europei è di sesso femminile ed è calcolato che le donne si laureino più velocemente dei propri colleghi maschi (e con voti migliori). Nonostante le leggi comunitarie e quelle di quasi tutti gli stati membri dell’Unione Europea vietino ogni tipo di disparità, compresa quella retributiva (principi sanciti anche negli atti che si pongono al vertice della scala gerarchica delle fonti: singole Costituzioni e Trattati, europei e internazionali), questo tipo di discriminazione resta un problema reale. L’Equal Pay Day (EPD) nasce proprio dall’esigenza di porre sotto i riflettori la questione e tentare la graduale eliminazione delle differenze di status sociale fondate sul genere. Volendo circoscrivere il punto di osservazione all’Italia ci accorgiamo che la materia è stata affrontata in maniera “strabica” dalle istituzioni nazionali rispetto a quelle comunitarie.
 Se, infatti, assai scarno sembra essere l’impegno del legislatore interno, notevole è invece l’attività degli organismi europei. Nel nostro paese il richiamo in Costituzione del principio secondo cui «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore» è rimasto quasi “lettera morta”; gli unici esiti normativi di qualche peso risiedono in tre atti, lontani tra loro e, grosso modo, di reciproca modifica: la legge n.903 del 1977, che applicava i principi contenuti nella prima direttiva europea in materia, armonizzandoli con la normativa nazionale; la legge n.125 del 1991 (“azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”); il decreto legislativo n.198 del 2006 che codifica attualmente il divieto di discriminazione salariale in Italia, affermando: «è vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale».
Se, infatti, assai scarno sembra essere l’impegno del legislatore interno, notevole è invece l’attività degli organismi europei. Nel nostro paese il richiamo in Costituzione del principio secondo cui «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore» è rimasto quasi “lettera morta”; gli unici esiti normativi di qualche peso risiedono in tre atti, lontani tra loro e, grosso modo, di reciproca modifica: la legge n.903 del 1977, che applicava i principi contenuti nella prima direttiva europea in materia, armonizzandoli con la normativa nazionale; la legge n.125 del 1991 (“azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”); il decreto legislativo n.198 del 2006 che codifica attualmente il divieto di discriminazione salariale in Italia, affermando: «è vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale».
Decisamente maggiore lo spazio dedicato alla materia a livello comunitario; a partire dal Trattato di Roma che nel 1957 istituiva la Comunità economica europea. Oltre all’enunciazione di principio indirizzata alla rimozione delle diseguaglianze di ogni tipo, gli stati membri si sono soffermati sul settore lavoro affermando l’altro cardine su cui s’installerà tutta la normazione successiva in tema di parità di retribuzione tra uomo e donna: «Ciascun Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro».
Dovremo però attendere quasi un ventennio affinché vedano la luce i primi atti concreti. È il 1975 quando la direttiva del Consiglio europeo n.117 apre un’intensa stagione di riforma del mercato del lavoro a livello comunitario, finalizzata all’eliminazione di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. In nome della “parità di trattamento”, nel giro di un triennio si susseguono tre importanti direttive: la già citata n.177, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla parità di retribuzione tra uomo e donna; la direttiva n.207 del 1976, per l’attuazione della parità di trattamento nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale nonché per un miglioramento delle condizioni di lavoro della donna; la direttiva n.7 del 1979, per una graduale attuazione dell’uguaglianza in materia di sicurezza sociale e previdenziale. Iniziative, queste, ripetute in futuro a cadenza decennale; ben presto, infatti, ci si accorse che le previsioni normative senza un’adeguata sensibilizzazione attorno al problema erano, all’atto pratico, ben poca cosa.
Ecco quindi, nel 1984, una Raccomandazione del Consiglio europeo che invita gli Stati membri, aldilà dell’attività legislativa, a coinvolgere la società civile: informare il grande pubblico e il mondo del lavoro del messaggio proveniente da Bruxelles; elaborare studi e analisi (qualitative e quantitative) sulla condizione lavorativa della donna; collaborare con le organizzazioni di settore nella costruzione di piani strategici. Un primo passo per creare una rete di comunicazione su una problematica che, fino a quel momento, non sembrava così sentita perché non valorizzata adeguatamente; un impegno concreto in capo ai paesi aderenti alla Comunità europea.
 Solo da questo momento in poi sembra muoversi qualcosa; non a caso appena tre anni dopo, nel 1989, vedrà la luce un altro dei pilastri della politica europea in materia di lavoro: la Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori (che, all’art.16, riprende il principio della parità di trattamento tra uomo e donna, ivi compresa quella retributiva). Ormai la strada è tracciata e gli anni ’90 rappresentano l’epoca sicuramente più prolifica, in cui il tema “parità di trattamento” diventa una priorità del legislatore europeo.
Solo da questo momento in poi sembra muoversi qualcosa; non a caso appena tre anni dopo, nel 1989, vedrà la luce un altro dei pilastri della politica europea in materia di lavoro: la Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori (che, all’art.16, riprende il principio della parità di trattamento tra uomo e donna, ivi compresa quella retributiva). Ormai la strada è tracciata e gli anni ’90 rappresentano l’epoca sicuramente più prolifica, in cui il tema “parità di trattamento” diventa una priorità del legislatore europeo.
Dapprima la direttiva n.97 del 1996 interviene a modificare parzialmente la precedente, in ossequio alle molte sentenze della Corte europea di giustizia. Appena un anno e arriva il primo atto concreto anche da parte della Commissione europea, che redige il “Codice di condotta per l’applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per lavoro di pari valore”. Nel Codice si procede ad un’analisi approfondita del fenomeno, individuandone le cause e provando ad avanzare soluzioni. Nel documento si prendeva atto che, nonostante gli sforzi profusi dalle istituzioni europee, ancora ampio rimaneva il divario tra i salari delle donne e quelli degli uomini (in tutti i paesi membri). Tra le cause: la “segregazione verticale e orizzontale” cui sono sottoposte le donne (le mansioni “femminili” sono generalmente le meno retribuite); i settori a predominanza maschile sono anche quelli che beneficiano di retribuzioni supplementari e di premi di produttività; un potere contrattuale femminile più basso; la necessità per la donna, in assenza di adeguate tutele, di optare in molti casi per lavori a tempo parziale per poter seguire la famiglia.
La Comunità europea non concederà più alibi agli Stati membri. Seguono altre due direttive: la n.13 del 2002, per l’introduzione nei singoli ordinamenti di organismi di promozione, analisi, controllo e sostegno per l’azzeramento delle discriminazioni fondate sul sesso (in Italia la “Commissione per le pari opportunità”, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita nel 2006). Ma, soprattutto, la n.54 del 2006 che, nel riprendere e riunire in un testo organico l’intera disciplina sulle pari opportunità, invita i governi ad affrontare il problema in collaborazione anche con le parti sociali, visto il persistere delle disparità; alla base vi è la constatazione che la parità di trattamento lavorativa e salariale non possa limitarsi a misure di carattere normativo. Un nuovo modo di affrontare la questione: «L’Unione europea e gli Stati membri – si legge nelle premesse al documento – dovrebbero continuare a favorire il processo di sensibilizzazione al problema della discriminazione in materia retributiva e un cambiamento d’approccio pubblico che coinvolga, per quanto possibile, tutte le forze interessate sia pubbliche che private. Il dialogo tra le parti sociali potrebbe fornire, a tal proposito, un importante contributo».
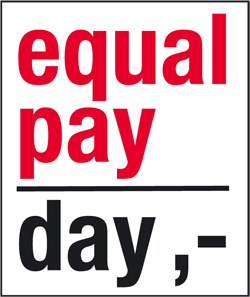 L’Equal Pay Day s’inserisce in questo solco. Nato negli Stati Uniti nel 1988 per iniziativa dell’Associazione BPW (Business and Professional Women) è una campagna di sensibilizzazione-denuncia per ridurre le disparità salariali nei confronti delle donne. Portato in Europa nel 2008 da BPW Germany, l’Equal Pay Day è già diventato un appuntamento fisso per accendere i riflettori sul problema. Una data simbolo, che varia di anno in anno: il giorno fino al quale la donna deve lavorare per guadagnare quanto i colleghi maschi hanno percepito nell’anno precedente (letteralmente significa proprio “il giorno per un’uguale busta paga”). In Italia l’Equal Pay Day è promosso dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari), una rete di donne imprenditrici, presente in 90 paesi dei 5 continenti; un’associazione che conta quasi 12.000 membri e che appartiene alla federazione Internazionale BPW. In pochi anni, grazie ai risultati ottenuti, l’Equal Pay Day ha saputo farsi conoscere talmente tanto che, dal 2011, è patrocinato dalla stessa Commissione europea. Nonostante tutto, infatti, il problema “pari opportunità” si ripropone anche nelle istituzioni comunitarie: su 29 Presidenti del Parlamento Europeo, soltanto 2 Presidentesse; sui 27 membri dell’attuale Commissione, solo 10 donne; appena il 34% degli Europarlamentari espressione del gentil sesso (nonostante la maggioranza della popolazione europea sia donna). Sicuramente l’obiettivo ultimo è ambizioso: riuscire ad anticipare l’Equal Pay Day fino a farlo coincidere con il 31 dicembre; questo significherebbe l’azzeramento del differenziale salariale uomo-donna.
L’Equal Pay Day s’inserisce in questo solco. Nato negli Stati Uniti nel 1988 per iniziativa dell’Associazione BPW (Business and Professional Women) è una campagna di sensibilizzazione-denuncia per ridurre le disparità salariali nei confronti delle donne. Portato in Europa nel 2008 da BPW Germany, l’Equal Pay Day è già diventato un appuntamento fisso per accendere i riflettori sul problema. Una data simbolo, che varia di anno in anno: il giorno fino al quale la donna deve lavorare per guadagnare quanto i colleghi maschi hanno percepito nell’anno precedente (letteralmente significa proprio “il giorno per un’uguale busta paga”). In Italia l’Equal Pay Day è promosso dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari), una rete di donne imprenditrici, presente in 90 paesi dei 5 continenti; un’associazione che conta quasi 12.000 membri e che appartiene alla federazione Internazionale BPW. In pochi anni, grazie ai risultati ottenuti, l’Equal Pay Day ha saputo farsi conoscere talmente tanto che, dal 2011, è patrocinato dalla stessa Commissione europea. Nonostante tutto, infatti, il problema “pari opportunità” si ripropone anche nelle istituzioni comunitarie: su 29 Presidenti del Parlamento Europeo, soltanto 2 Presidentesse; sui 27 membri dell’attuale Commissione, solo 10 donne; appena il 34% degli Europarlamentari espressione del gentil sesso (nonostante la maggioranza della popolazione europea sia donna). Sicuramente l’obiettivo ultimo è ambizioso: riuscire ad anticipare l’Equal Pay Day fino a farlo coincidere con il 31 dicembre; questo significherebbe l’azzeramento del differenziale salariale uomo-donna.
Il supporto dell’Unione europea potrebbe essere decisivo.
Marcello Gelardini





